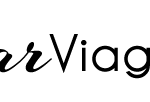Domani sera (martedì 4 febbraio) alle 21, presso la Saletta Vallini accanto alla biblioteca, sarà presentato il libro di Simone Caffaz intitolato “La scatola di legno”, edito da Marchetti. Questo evento segna l’ultima delle iniziative organizzate dall’amministrazione Giannoni in occasione del Giorno della Memoria 2025, sotto la supervisione dell’assessore alla memoria Simone Balsanti e del Tavolo della Memoria. A moderare l’incontro ci sarà il professore di storia dell’università di Padova, Lorenzo Pera. La narrazione affronta il tema degli ebrei in Italia, in particolare durante la Shoah, includendo le esperienze personali dei nonni dell’autore e le loro peripezie per sfuggire ai nazisti, vicende collegate a Santa Croce sull’Arno dopo l’8 settembre e al Valdarno, luogo chiave nella storia familiare di Caffaz.
Qual è stata l’ispirazione per la scrittura di questo libro?
“L’idea è nata da una serie di conversazioni che ho avuto nel 2006 con mia nonna. Esterina, che aveva gestito un negozio di abbigliamento fino all’età di 85 anni, mi chiamò pochi giorni prima di chiudere l’attività e mi chiese di andare a trovarla. Durante l’incontro, mi disse che voleva mostrarmi alcune cose che aveva conservato in una scatola di legno, da cui deriva il titolo del libro.
All’interno della scatola, mia nonna aveva custodito documenti, libri, foto e giornali. Questi materiali raccontano la sua esperienza personale, quella della sua famiglia e della comunità ebraica italiana fino ai giorni nostri. Le nostre conversazioni proseguirono per vari giorni, il materiale narrativo era abbondante e non fu facile organizzarlo, considerando che mia nonna aveva 85 anni e aveva frequentato solo la quarta elementare. Ho dunque dovuto dare una struttura al racconto.”
Qual è la storia di sua nonna che la porta a Santa Croce sull’Arno?
“Per sfuggire ai nazisti, mia nonna dovette spostarsi di continuo dopo l’8 settembre. Quando mio nonno venne arrestato nella nostra zona, mia nonna si trovava a Santa Croce, dove viveva in un dormitorio che accoglieva molti ebrei toscani in fuga dalla persecuzione. Passò un periodo in quella struttura e in seguito si mobilitò per liberare mio nonno, imprigionato a San Miniato, dove rischiava di essere deportato a Fossoli, come molti altri ebrei catturati in Italia. Fortunatamente, con una certa astuzia, riuscì a farlo liberare, corrompendo il direttore della struttura.”
Cosa rende unica la narrazione di sua nonna oltre alla sua storia familiare?
“La cosa più significativa della narrazione di mia nonna è che mette in luce una parte della storia degli ebrei italiani e della Shoah che riguarda non i grandi centri urbani, ma cosa accadde a chi viveva in periferia e nei piccoli comuni. Chi viveva in periferia, infatti, non aveva accesso a reti di protezione costituite da altri ebrei o associazioni come la Delasem, che aiutavano a sfuggire o sopravvivere alla persecuzione nazista.
Negli ambienti periferici, gli ebrei svilupparono strategie alternative per la sopravvivenza. Ad esempio, una pratica comune era quella di cambiare abitazione frequentemente, scambiandosi le case anche con ebrei residenti lontano. Con questo libro cerco di raccontare anche questi aspetti della persecuzione.”
Cosa le ha raccontato sua nonna riguardo alla persecuzione nei piccoli centri, come Carrara?
“Spesso in Italia si tende a considerare le leggi razziali e la persecuzione nazista come fenomeni distanti dalla nostra realtà, specialmente nei piccoli centri. Ho sentito dire: ‘Ma da noi le leggi razziali non vennero applicate’, riferendosi a queste comunità. Questo non è del tutto vero. In effetti, le leggi razziali di Mussolini furono applicate anche nei piccoli comuni, e la persecuzione da parte dei nazisti fu reale. Certamente, in alcuni casi le leggi non vennero applicate in modo rigoroso, ma ci furono comunque discriminazioni anche nei centri minori. Nella mia esperienza a Carrara, ho trovato oltre mille documenti nell’archivio di Stato riguardanti condotte discriminatorie verso gli ebrei.”
Qual è il quadro della comunità ebraica in Italia durante il periodo fascista emerso dalla storia di sua nonna e dalle sue ricerche?
“Sostanzialmente, gli ebrei si dividevano in due grandi gruppi: i simpatizzanti del regime, che sostenevano il fascismo poiché la loro identità italiana prevaleva su quella ebraica, e coloro che rimasero neutri o contrari, spesso a causa della loro adesione al sionismo e del desiderio di fondare uno stato di Israele. All’interno delle comunità ebraiche ci furono forti conflitti riguardo alla posizione rispetto al fascismo, e alla fine prevalsero le posizioni sioniste o neutraliste. Questa fu una delle divisioni principali nelle comunità ebraiche dell’epoca.”
La sua famiglia è riuscita a salvarsi completamente dalla Shoah o avete perso qualcuno nella persecuzione?
“Fortunatamente, la mia famiglia si salvò quasi completamente; solo un cugino di mio nonno fu catturato e morì ad Auschwitz.”
Che cosa le ha raccontato sua nonna riguardo ai concittadini e agli italiani in quel periodo storico, e quale quadro emerge dal libro?
“Le reazioni degli italiani furono simili in tutto il Paese. C’erano quelli che aiutarono gli ebrei, ma anche delatori e chi si voltò dall’altra parte. Il male era presente ovunque. La situazione attuale ci consente di affermare che in Italia ci fu male come altrove, ma forse anche più bene. Oggi, l’Italia, pur non avendo mai avuto una densità di popolazione ebraica particolarmente alta rispetto a paesi come la Polonia o altre nazioni dell’est europeo, è l’ottavo paese al mondo per numero di ‘Giusti tra le Nazioni’ riconosciuti da Yad Vashem.”
Lei ha una carriera politica di centrodestra e si identifica con i valori della destra liberale moderata. Come concilia questa appartenenza politica con la sua storia familiare e quella degli ebrei in Italia?
“Non ho alcun problema a essere un ebreo italiano che milita nel centrodestra come liberale laico. Non devo conciliare nulla; ho trovato amici che condividono le mie idee e altri che hanno posizioni diverse. Tuttavia, posso dire che negli ultimi anni ho notato che Israele è difeso più dal centrodestra di Meloni che dal centrosinistra. In passato ho avvertito atteggiamenti ambigui sia da esponenti del centrodestra che del centrosinistra, ma tali atteggiamenti sono sempre più rari. Esistono certamente settori marginali che mantengono atteggiamenti antisemiti sia a destra che a sinistra, ma rimangono dei paria culturali. Purtroppo, i dati indicano che l’antisemitismo è in aumento negli ultimi anni, e considero questo un problema che va al di là della mia esperienza politica e che reputo preoccupante.”