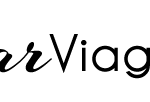ROMA (ITALPRESS) – I disturbi del comportamento alimentare (DCA) comprendono un insieme complesso di patologie psichiatriche caratterizzate da una relazione disfunzionale con il cibo, il corpo e l’immagine personale. Tra i principali disturbi figurano l’anoressia nervosa, la bulimia nervosa e il disturbo da binge-eating. Secondo il ministero della salute, si stima che circa 3 milioni di persone in Italia soffrano di un disturbo alimentare, con un incremento del 30% a seguito della pandemia di Covid-19. La fascia d’età più colpita è tra i 12 e i 25 anni, con un aumento allarmante dei casi tra bambini, adolescenti e anche adulti. Questi sono alcuni degli argomenti trattati da Patrizia Todisco, psichiatra, psicoterapeuta e presidente della Società Italiana per lo Studio dei Disturbi del Comportamento Alimentare (SISDCA), in un’intervista con Marco Klinger, per il programma Medicina Top dell’agenzia di stampa Italpress.
“Non abbiamo dati di incidenza reali, in quanto in Italia non esiste un registro per queste patologie; possiamo solo identificare i pazienti che si rivolgono ai centri specializzati – ha esordito Todisco – Secondo i dati clinici, sembra che la pandemia abbia esacerbato situazioni preesistenti. Queste patologie sono multifattoriali e il Covid-19, come fattore stressante, ha portato persone già suscettibili a svilupparle, attivate da opportune circostanze come l’isolamento e una maggiore esposizione ai social network.”
Molti credono erroneamente che l’anoressia sia il disturbo alimentare più comune, ma in realtà il disturbo più prevalente è il binge-eating: “Sebbene l’anoressia sia storicamente considerata il principale disturbo alimentare, non è la patologia più diffusa; al contrario, il disturbo da binge-eating è quello predominante – ha spiegato – Colpisce persone di tutte le età, caratterizzandosi per abbuffate, con un aumento di peso poiché i soggetti non compensano con digiuno, vomito o iperattività. In Italia, circa 3 milioni e mezzo di persone soffrono di questi disturbi alimentari.”
Riguardo all’incidenza della genetica: “È un concetto piuttosto ampio; chi ha in famiglia qualcuno che ha sofferto di un disturbo alimentare o di un’altra malattia psichiatrica è sicuramente più predisposto – ha precisato Todisco – La componente genetica è stata particolarmente evidenziata nell’anoressia nervosa, definita metabolico-psichiatrica. Questi individui sembrano essere constitutionalmente magri, in quanto presentano un assetto genetico nettamente diverso da quello che predetermina un aumento di massa grassa.”
I trattamenti per i disturbi alimentari variano: “Queste patologie sono complesse e serie, richiedono un approccio multidisciplinare e integrato. Essere un buon psicoterapeuta non basta – ha ammesso – Le persone devono sentirsi comprese; non si tratta solo di affrontare il sintomo alimentare, ma di considerare l’importanza che attribuiscono al peso, all’aspetto fisico e al cibo nell’autovalutazione. È fondamentale esaminare il problema sotto la superficie e scoprire dove risiede il vero dolore. Il paziente deve essere protagonista del percorso insieme a tutti i professionisti coinvolti.”
Per riconoscere i segnali di un DCA: “In adolescenza, è comune notare diete improvvise o un aumento dell’attività fisica. Altri segnali possono includere la perdita di interesse per le attività sociali, come uscire con amici, o un controllo ossessivo sul peso del cibo… Non è sempre facile ottenere la collaborazione di questi pazienti – ha aggiunto Todisco – Queste patologie sono funzionali all’individuo e spesso vengono nascoste; frequentemente arrivano in terapia dopo anni, perché la malattia sembra conferire loro un certo vantaggio.”
“Parlare di una guarigione definitiva dai disturbi alimentari è molto complicato. Gli studi indicano che circa un terzo dei pazienti guarisce, un terzo migliora e un terzo presenta una lunga storia clinica – ha osservato – È fondamentale lavorare non solo sulla sintomatologia, ovvero sul cibo e sul peso, ma soprattutto sulla psicopatologia, poiché di solito sono associati disturbi d’ansia e dell’umore.”
“La riabilitazione deve avere un approccio biopsicosociale, integrando queste tre componenti – ha ribadito – Dobbiamo distinguere tra la remissione dei sintomi, che può verificarsi, ad esempio, con l’innamoramento o la nascita di un figlio, e la risoluzione della psicopatologia, per la quale sono necessarie lunghe terapie.” Infine, sui segnali d’allerta per riconoscere i disturbi del comportamento alimentare e prevenirne l’insorgenza: “Innanzitutto, è fondamentale non enfatizzare l’attenzione su cibo e peso nell’ambito familiare, cercando di mangiare insieme e osservando i comportamenti alimentari dei figli. Inoltre, è importante prestare attenzione quando un adolescente esprime il desiderio di perdere peso; non deriderlo se ha un peso superiore alla media o mostra imbarazzo – ha concluso – È cruciale promuovere una dieta sana, ma evitare rigidità e estremismi.”
– foto tratta da video Medicina Top –
(ITALPRESS).