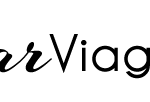Il Giorno della memoria è concepito come un’esperienza di esplorazione. Un’esplorazione che immerge nel passato per riportare a galla elementi del presente, equipaggiando le menti con una maggiore consapevolezza e uno sguardo critico. È un percorso per comprendere come le deportazioni nei campi di sterminio nazisti, inclusi quelli degli ebrei, siano emerse, senza ignorare i pericoli di discriminazione, pregiudizi e la continua resistenza all’accettazione della diversità, che persiste ancora oggi.
Da oltre vent’anni, la Regione Toscana celebra il Giorno della memoria, e anche quest’anno ha organizzato un evento al Teatro del Maggio Fiorentino, accogliendo circa un migliaio di studenti che sono giunti in treno da diverse località della Toscana, con molti altri collegati online.
Questo viaggio è fatto di numeri, ma anche di volti e racconti. Sono stati trattati numerosi temi: l’assurdità del concetto di “razza pura”, la memoria che implica non solo sentimenti, ma anche (e principalmente) conoscenza, il pericolo di una società costruita sull’esclusione, l’indifferenza che induce responsabilità, il falso mito degli italiani brava gente e la complicità degli italiani nel sistema di deportazione. E poi la necessità della pace, oggi più che mai.
Quattro ore intense di interventi. Con due testimoni dirette delle atrocità dei campi di sterminio: Andra e Tatiana Bucci, instancabili nel loro racconto ogni anno a nuove generazioni. Deportate a soli quattro e sei anni nel terribile Birkenau, furono scambiate per gemelle dal dottor Mengele, il che garantì loro la salvezza durante la prima selezione all’arrivo, mentre altri bambini, anziani e persone non idonee al lavoro venivano inviati direttamente alle camere a gas.
Quando, a metà mattinata, salgono sul palco, gli studenti ascoltano affascinati. Appena scese, alcuni di loro si avvicinano, cercando una parola, un gesto, una carezza. Sul palco, Andra e Tatiana raccontano alternativamente le porte scorrevoli che hanno aperto in quel periodo della loro vita. Non nascondono il peso della memoria, ma sottolineano l’importanza di continuare a narrare. Ricordano il loro cuginetto Sergio, che non ha superato le atrocità, trasferito da Auschwitz a un campo vicino ad Amburgo, insieme ad altri bambini, utilizzati come soggetti per esperimenti sulla tubercolosi, per poi essere uccisi all’arrivo degli Alleati, nel tentativo di eliminare ogni prova dei crimini perpetrati.
Raccontano dei momenti strazianti di quando la loro nonna si inginocchiò in cerca di pietà per loro, quella notte di fine marzo del 1944, quando tedeschi e italiani irrompevano nella loro casa a Fiume, e ricordano il lungo viaggio ammassati in un convoglio verso Trieste e poi verso Auschwitz. Parlano di come sono state in grado di sopravvivere, di come la loro mente ha trovato un modo per adattarsi all’oscurità e alla separazione da loro madre, e del centro di raccolta dove, dopo la liberazione, furono assistite a Praga e successivamente in Inghilterra, prima di tornare a Roma, anni dopo, trovandosi in fila con altre persone che cercavano notizie di deportati scomparsi.
“Sono tornata a Trieste qualche anno fa” – dice Tatiana – “e nel rivedere il silos di fronte alla stazione ferroviaria, abbandonato e ora rifugio per migranti in fuga che arrivano in Italia a piedi dai Balcani, ho rivisto Birkenau”. Poi accenna alla situazione in Israele e alla Striscia di Gaza. L’anno scorso, sempre a Firenze, Andra aveva confessato di aver dubitato, all’inizio della guerra, se ogni racconto e condivisione fosse stata una fatica vana, per poi convincersi subito che, proprio per questo, raccontare è fondamentale. Oggi Tatiana si limita a esprimere un desiderio: “Vorrei semplicemente la pace”.
Pace richiesta anche da padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, che oltre un anno fa ha organizzato una fiaccolata a Firenze insieme a ebrei e musulmani, rendendo la città “un profeta di pace, unità e generatore di futuro”. Un discorso che si oppone all’indifferenza. “La memoria”, afferma, “non è nostalgia: nostalgia è solo rimpianto. La memoria è un seme che cresce e ha il potere di spezzare quel terribile filo spinato che sembra essere l’unico confine tra le diversità.”
La mattina al Maggio Fiorentino è iniziata con la musica dell’Orchestra multietnica di Arezzo e dell’Alexian Group di Santino Spinelli: melodie e armonie ebraiche e rom si intrecciano. Enrico Fink, musicista e presidente della comunità ebraica di Firenze, esegue “El male Rachamim”, una poesia spesso recitata come preghiera, seguita da interventi dell’assessora all’istruzione e alla memoria Alessandra Nardini, della sindaca di Firenze Sara Funaro e del direttore dell’ufficio scolastico regionale toscano Ernesto Pellecchia.
Il presidente della Toscana Eugenio Giani sale sul palco, conferendo il Pegaso d’oro, il massimo riconoscimento della Regione, alle sorelle Bucci. Dopo un intermezzo musicale, è il turno di Sofia Canovaro, presidente del Parlamento regionale degli studenti, che si concentra sul clima attuale di apologia del fascismo e sul revisionismo della storia del Novecento, evidenziando l’importanza della memoria. A seguire, la docente di storia contemporanea Isabella Insolvibile introduce gli anni delle deportazioni mentre il viaggio continua con lo storico Luca Bravi e la giornalista Chiara Brilli, che esplorano, oltre al dramma della Shoah, la deportazione di oppositori politici, internati militari italiani, membri della comunità Lgbtqia+, rom e sinti, testimoni di Geova e persone con disabilità o disturbi psichici, dall’inizio di un’aberrazione sociale costruita sugli esclusi, eliminando coloro che venivano considerati solo un costo o estranei a certe norme.
È un viaggio dove a prevalere sono nuovamente i volti, le voci e le storie. “Perché”, come dice Bravi dal palco, “Auschwitz non può essere solo raccontata o visitata; bisogna comprendere il percorso che ha portato a quel punto: dobbiamo attraversarlo, e questo ci riporta al presente”.
Si narra così la storia degli Imi, gli internati militari italiani, e di Michele Montagono, classe 1921, studente di giurisprudenza proveniente da una famiglia fascista, che, dopo l’8 settembre 1943, insieme a quasi 700 mila soldati italiani, si rifiutò di riconoscere la Repubblica di Salò, diventando antifascista. Questi soldati non furono più considerati prigionieri di guerra dopo il 20 settembre e vennero impiegati come manodopera per l’industria bellica, privi di protezione della Convenzione di Ginevra del 1929 e della Croce Rossa internazionale.
Si racconta anche di Marcello Martini, giovane deportato politico toscano, ancora adolescente, a Mauthausen, un campo ottuso dove la sopravvivenza era rara, poiché la morte avveniva attraverso il lavoro. Marcello è stato uno dei pochi sopravvissuti e ha spesso fatto da testimone, parlando con gli studenti durante il treno della memoria. Ricordava loro: “Siate curiosi e imparate, non solo a scuola, perché ti possono togliere tutto, e puoi trovarti letteralmente nudo come me nel campo, ma ciò che sai fare non te lo leva nessuno.”
Sul palco le storie si intrecciano, ma la mattinata volge al termine e il programma richiede di accelerare i ritmi. Noel Maggini, stilista sinto di Prato, discute del genocidio degli rom e sinti, raramente documentato, e delle discriminazioni che perdurano. Racconti di pregiudizi non estinti riguardano anche la comunità Lgbtqia+, che subì deportazioni nei campi di concentramento e fu ghettizzata. Già dal 1871, il codice penale tedesco aveva criminalizzato le relazioni tra uomini. Con i nazisti, nel 1935, quell’articolo fu amplificato e venne abrogato solo nel 1994, sebbene attenuato nel 1969. Ci sono anche storie inedite o poco conosciute, come quelle dei Testimoni di Geova, banditi dal governo tedesco nel 1933, che furono vittime di persecuzioni e deportazioni, fucilati, impiccati e, in alcuni casi, decapitati con la ghigliottina, semplicemente perché considerati diversi.
Infine, nell’ultima parte dell’evento, Annalisa Savino, dirigente scolastica del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Firenze, parla ai ragazzi e con le sue osservazioni fa riferimento ai recenti atti di violenza perpetrati da un gruppo di giovani di estrema destra, risuonando tra il pubblico con una lettera aperta indirizzata alle sue studentesse e studenti. Sottolinea l’importanza della formazione all’antifascismo nelle scuole. Non appena scorrono i titoli di coda, l’assessora Nardini e Ugo Caffaz, consulente per le politiche della memoria ed ideatore del treno della memoria toscano, si prendono il tempo per ringraziare i numerosi giovani presenti e attenti.